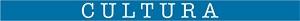«Si tratta di dare autonomia alle superfici. Una grammatica il cui punto di partenza è il concetto di luogo per cui lo spazio diventa un sistema di luoghi che si uniscono e si separano e in questa continua dialettica trovano il proprio punto di equilibrio.»
Così dichiarava Paolo Portoghesi riferendosi alla sua predilezione per lo stile Thonet che caratterizza l’abitazione di Calcata in cui risiedeva con la moglie, Giovanna Massobrio, dal 1974, anno del trasferimento da Roma. Parole che costituiscono il cosiddetto elogio della linea curva e non può non evocare la casa di “don” Antoni Gaudì sul poggio del Parco Güell, a Barcellona. Per entrambi, l’architettura non irrompeva nello spazio per antropizzarlo, quanto piuttosto vi trasferiva, nel caso dello spagnolo, una profonda spiritualità religiosa, mentre in quello di Portoghesi esprimeva un’adesione alla contemporaneità che andava dal periodo postmoderno alla geoarchitettura, ossia alla decrescita, teorizzata da Serge Latouche, nel segno di Le Corbusier.
La sua scomparsa è quindi anche il silenzio perpetuo di una voce culturale che non ha sostituti nella corale dello sviluppo. Piuttosto, ne affretta la degenerazione in cacofonia. Al suo posto rimarranno tanti, troppi, reinventori dell’estetica edilizio come affermazione di capitale e potere, non di stile. Lo si vede già nei picchi di follia economica che caratterizzano certi nuovi ecomostri nel centro di Milano.
Paolo Portoghesi, malgrado la sua fama in vita, cercava ben altro. La lunga e mai rinnegata militanza socialista per lui fu testimonianza di ideali e non di ideologia. L’apporto accademico, la produzione saggistica, gli esempi concreti e innovativi della sua ricerca compongono un ritratto che fa di un uomo attuale già un classico.
Dopo Portoghesi, non basteranno i nomi sacri dell’architettura italiana a cavallo dei millenni per contendere ad altri Paesi un primato edificatore che fu peninsulare fin dai tempi della civiltà greco-romana.