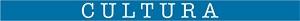Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, chiude il programma di fact-checking e strizza l’occhio a Trump. Otto anni fa, Trump e la Brexit scatenarono il timore che i social media stessero corrodendo la realtà. Ora, quella narrazione si sta sgretolando. La vittoria di Donald Trump è solo l’ultimo colpo alla narrazione della Grande Disinformazione, scrive su Polìtico Laurie Clarke, facendo dei distinguo: “Quando Donald Trump vinse nel 2016, la colpa fu data ai social media. Non questa volta. La prima vittoria di Trump alle elezioni presidenziali americane di quell’anno, più il voto shock nel Regno Unito per lasciare l’Unione Europea, hanno fatto sì che le classi chiacchierone su entrambe le sponde dell’Atlantico si affannassero per trovare una spiegazione. Hanno presto trovato i social media. Nel caso della Brexit, si sosteneva che gli elettori erano stati plagiati dall’oscura società di analisi dati Cambridge Analytica; nel caso di Trump, a farne le spese erano stati i troll russi”. “Tutti dicevano che la colpa era della tecnologia”, spiega Reece Peck, professore associato di giornalismo e comunicazione politica alla City University di New York. “Questi algoritmi sono da biasimare”. Ciò che seguì fu quasi un decennio di allarme per la disinformazione, con i legislatori che si tormentavano su quali idee le piattaforme dei social media avrebbero dovuto consentire di propagare e si torcevano i denti per come tutto ciò stava corrodendo irrimediabilmente le fondamenta della società. Una vivace industria artigianale, soprannominata “Big Disinfo”, è nata per combattere contro le cattive informazioni. “Le ong - scrive Clarke - hanno riversato denaro in gruppi che si impegnavano a difendere la democrazia dai mercanti di falsità, mentre le operazioni di fact-checking promettevano di pattugliare i confini della realtà. Tuttavia non tutti erano convinti della minaccia”. A partire dal ceo di Facebook Mark Zuckerberg, che già nel 2016 attaccò la sinistra affermando che c’era “una profonda mancanza di empatia nell’affermare che l’unica ragione per cui qualcuno avrebbe potuto votare in quel modo era perché aveva visto delle fake news”. Otto anni dopo, dopo la seconda decisiva vittoria di Trump, la posizione di Zuckerberg risuona nuovamente. E hai voglia a dare addosso agli americani giudicandoli rozzi ed ignoranti. Non si può fare un ragionamento superficiale. Questa volta, “non c'è nessun grande mistero, tipo, wow, perché è successo questo?” sostiene Kelly McBride, ricercatrice di etica dei media al Poynter Institute. “Nessuno è stato ingannato a votare per Donald Trump”. E la vittoria di Trump - conclude Clarke - è solo l’ultimo colpo alla narrazione della Grande Disinformazione che ha guadagnato importanza negli anni recenti. Lo studio della disinformazione è precedente al 2016, ma il settore ha vissuto una rinascita dopo Trump. L’attenzione si è rapidamente spostata dalla disinformazione vera e propria (falsità diffuse intenzionalmente per ingannare) alla categoria più ampia e pervasiva del discredito, che si diffonde più o meno inconsapevolmente tra la popolazione. Il clamore è cresciuto durante la pandemia di Covid, innescando la cosiddetta “infodemia”, valanga di falsità che il presidente Joe Biden aveva ammonito stesse “uccidendo le persone”. Ciononostante, quattro anni dopo, Trump è di nuovo presidente eletto (e di nuovo su Facebook, da cui era stato bandito), lo scetticismo sui vaccini è in aumento e la fiducia nei media continua il suo rapido declino. In tale contesto, i ricercatori di disinformazione oltreoceano stanno seriamente iniziando a mettere in discussione la loro utilità. “C'è attualmente una crisi nel campo degli studi sulla disinformazione”, ammetteva un articolo di ottobre sulla Misinformation Review dell’Università di Harvard. “Per quasi un decennio”, la disinformazione è stata una fissazione centrale delle élite politiche, delle organizzazioni non-profit e dei media, hanno scritto gli autori. Nonostante ciò, “a volte può sembrare che il campo non sia più vicino a rispondere alle domande di base sugli impatti della disinformazione nel mondo reale, come i suoi effetti sulle elezioni o i collegamenti con l’estremismo e la radicalizzazione”. Il loro lavoro è frustrato da conversazioni “incredibilmente polarizzanti” sul ruolo che la disinformazione gioca nella società. Ad esempio, se “Facebook abbia influenzato in modo significativo i risultati delle elezioni del 2016” - il che, a otto anni di distanza, è ancora inconcludente, sebbene gli studi abbiano sollevato dubbi sul fatto che le bot farm russe abbiano avuto molto a che fare con ciò. “Penso che le persone all’interno del settore abbiano capito che l’informazione e il modo in cui plasma la nostra visione del mondo sono sicuramente cose importanti da capire”, ha affermato Felix Simon, ricercatore in comunicazione e ricercatore associato in intelligenza artificiale e notizie digitali presso il Reuters Institute for the Study of Journalism. L’opinione prevalente tra giornalisti e studiosi era che si trattasse di un problema “dal basso verso l’alto”: attori nefasti, probabilmente finanziati da stati stranieri ostili, stavano inquinando le fondamenta del discorso pubblico, contaminando il resto dell’ecosistema. “C’era la visione del 'cielo che cade' che usciva dalle elezioni del 2016 esacerbata dal fatto che questo era il territorio dei principali media, quindi sembrava particolarmente importante soprattutto per i giornalisti”, ha affermato Matthew Baum, professore di comunicazioni globali all’Università di Harvard. Un sondaggio Pew del 2022 ha rilevato in effetti che il 71% dei giornalisti riteneva che le notizie e le informazioni inventate fossero un “problema molto grande”, rispetto al 50% degli adulti americani. Alcuni studiosi ritengono che l’inevitabile soggettività implicita nella definizione di “disinformazione” la renda del tutto inappropriata come campo di indagine scientifica. “Sebbene le informazioni fuorvianti siano diffuse e dannose, non può esistere, o meglio, non dovrebbe esistere, una scienza dei contenuti fuorvianti”, ha scritto all’inizio di quest’anno Dan Williams, professore associato di filosofia presso l’Università del Sussex. È fuorviante tentare di misurare l’esposizione delle persone a contenuti presumibilmente fake o la loro “suscettibilità” a essi, ha scritto Williams. “Ed è estremamente fuorviante delegare ad una classe di cosiddetti esperti di disinformazione il compito di determinare quali affermazioni vere siano comunque fake ”. Intuendo il cambiamento radicale, le piattaforme hanno lentamente adattato il loro approccio alla disinformazione. Dopo i suoi commenti scettici in seguito alle elezioni del 2016, Zuckerberg ha rapidamente cambiato la sua posizione sulle “fake news”. Lo scorso agosto ha inviato una lettera ai repubblicani del Congresso esprimendo rammarico per il fatto che Meta avesse ceduto alle pressioni dell’amministrazione Biden per censurare i contenuti relativi al Covid-19. Ha affermato che la società sarà “pronta a reagire” la prossima volta. “Uno come Zuckerberg, si lascia trasportare dal flusso del potere. Non ha opinioni politiche particolarmente forti, a parte l’impegno per la ricchezza e la deregulation governativa”, taglia corto Alice Marwick, direttrice della ricerca presso Data & Society, istituto di ricerca non-profit. I sostenitori di una moderazione robusta dei contenuti hanno criticato i cambiamenti, ma il controllo del discorso politico resta sempre stato controverso.
Raffaella Vitulano
Scenari
Perché negli Usa il panico della disinformazione è finito

E-dicola
Video
Mostre
La forza innovatrice di Caravaggio

A quindici anni dall’ultima grande mostra Roma propone un nuovo importante evento dedicato all’artista alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini
Magazine
Via Po Cultura

Vengono oggi ripubblicate da Mimesis (sempre a cura di Piero Di Giovanni che le aveva già curate per Laterza nel 1994 e nel 2005) le lezioni di Nietzsche con un titolo curioso e affascinante: “I filosofi preplatonici”
Libri
Naufraghi per scelta

La versione italiana di “The Shelter from the Spray” (1952) è la cronaca di 23 mesi trascorsi da due fratelli tedeschi su un desolato lembo di terra nell’Atlantico meridionale