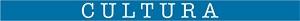Il sistema idrico italiano resta del tutto inefficiente. Lo è a causa di una rete mai rinnovata, soprattutto al Sud. Il volume delle perdite idriche totali, nella sola fase di distribuzione dell'acqua, è pari a 3,4 miliardi di metri cubi. È una cifra spropositata e, cosa più allarmante, non è in calo rispetto al 2020. Di fatto, sprechiamo il 42,4% dell'acqua immessa in rete. Ma a pesare sul sistema idrico è anche l’inquinamento da agricoltura che, secondo l’ultimo report della Commissione Ue sul tema, “rappresenta per l'Italia la causa principale di pressione delle acque di superficie, con oltre un terzo dei corpi idrici del Paese interessati”.
Il report dedicato all'Italia osserva che le “principali pressioni sui corpi idrici superficiali” segnalate dal nostro Paese sono l'inquinamento diffuso da agricoltura e la gestione delle acque reflue urbane, su cui restiamo indietro nell'attuazione delle norme Ue. Nonostante un aumento riconosciuto dall'Ue come “costante” negli ultimi dieci anni dei terreni adibiti al biologico (17%), l'inquinamento diffuso da agricoltura - dovuto all'uso intensivo di nutrienti e pesticidi, insieme allo sfruttamento delle acque - rimane una “sfida” che l'Italia deve affrontare per migliorare qualità e quantità delle acque, trovandosi sempre più spesso a dover affrontare fenomeni di siccità e scarsità d'acqua. Al Paese si raccomanda, tra le altre cose, di stimare “in modo trasparente” gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento da nutrienti e pesticidi. Non solo agricoltura: l'inquinamento da cattiva gestione delle acque reflue urbane resta la seconda pressione “significativa” che interessa un quarto dei corpi idrici superficiali. L'Italia - ricorda la Commissione europea - è in ritardo rispetto alla media europea nell'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, con solo il 56% delle acque reflue urbane trattate secondo i requisiti delle norme Ue (la media europea è del 76%) e con alcune carenze nelle infrastrutture necessarie per il trattamento delle stesse.
C’è poi, ovviamente, il fattore climatico. Scarsità d'acqua e siccità sono riconosciute dall'Ue come un “problema serio” in Italia, colpendo da qualche anno “in modo significativo, la produzione agricola, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico pubblico e la produzione di energia (termica e idroelettrica”. Per questa ragione è ancora più urgente intervenire su inquinamento agricolo, trattamento delle acque reflue, sprechi della rete idrica. L'impatto della siccità, ricorda infatti la Commissione europea, “è destinato ad aumentare nei prossimi anni, poiché gli effetti del cambiamento climatico si faranno sentire sempre di più”. All'Italia si raccomanda di aumentare la propria resilienza ai cambiamenti climatici, anche considerando sistematicamente soluzioni basate sulla natura per aumentare le riserve idriche e bilanciando le esigenze di adattamento con gli impatti sull'idromorfologia dei corpi idrici. La scarsità d'acqua non è però ricondotta solo agli effetti dei cambiamenti climatici in aumento ma anche ad azioni dell'uomo: secondo i numeri del rapporto, circa il 77% dei corpi idrici sotterranei soffre di scarsità d'acqua a causa delle “pressioni di estrazione” da parte di acquedotti pubblici, industria, agricoltura, allevamenti ittici, energia idroelettrica, acque di raffreddamento e circa tre quarti dei corpi idrici sotterranei che rischiano di non raggiungere un buono stato quantitativo entro il 2027. Le estrazioni sono considerate una “pressione significativa” anche per circa il 26% del totale dei corpi idrici superficiali”.
Ilaria Storti
Attualità
Clima e inquinamento agricolo danneggiano il sistema idrico italiano
E-dicola
Video
Mostre
La forza innovatrice di Caravaggio

A quindici anni dall’ultima grande mostra Roma propone un nuovo importante evento dedicato all’artista alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini
Magazine
Via Po Cultura

Vengono oggi ripubblicate da Mimesis (sempre a cura di Piero Di Giovanni che le aveva già curate per Laterza nel 1994 e nel 2005) le lezioni di Nietzsche con un titolo curioso e affascinante: “I filosofi preplatonici”
Libri
Naufraghi per scelta

La versione italiana di “The Shelter from the Spray” (1952) è la cronaca di 23 mesi trascorsi da due fratelli tedeschi su un desolato lembo di terra nell’Atlantico meridionale